Problemi irrisolvibili con il neodarwinismo: gli esperti chiedono una nuova teoria dell’evoluzione
Recentemente, ci sono state alcune sorprendenti confessioni da parte di persone convinte della visione prevalente delle origini. Questa, ovviamente, è l’evoluzione neodarwiniana, l’idea che mutazioni genetiche benefiche sorte nel corso del tempo abbiano fornito la materia prima per la selezione naturale darwiniana. In questo modo, gli evoluzionisti affermano che errori casuali nel DNA, uniti alla sopravvivenza del più adatto, hanno generato ogni organismo vivente sul pianeta, dalle diatomee ai passeriformi, dai lieviti agli yak, dagli pneumococchi agli architetti navali. I titoli di questo articolo sono tutti citazioni dirette di evoluzionisti apparse di recente.
“La maggior parte dei nostri alberi genealogici potrebbe essere sbagliata”
Nel giugno 2022, l’Università di Bath (Regno Unito) ha pubblicato un comunicato stampa del professor Matthew Wills e colleghi, provocatoriamente intitolato “Uno studio suggerisce che la maggior parte dei nostri alberi genealogici potrebbe essere sbagliata”.1 In effetti, la loro ricerca pubblicata su Communications Biology ha davvero creato confusione.2
Negli ultimi 20 anni, i biologi evoluzionisti hanno dovuto affrontare sempre più spesso la scomoda realtà che i dati della biologia molecolare spesso contraddicono gli alberi genealogici evolutivi tradizionali. È noto che il modo principale in cui gli evoluzionisti hanno raggruppato gli esseri viventi è stato in base alle loro somiglianze anatomiche. Questo, a sua volta, alimenta le discussioni sull’omologia. Gli scienziati evoluzionisti di solito partono dal presupposto che “l’omologia è una somiglianza dovuta a un’ascendenza comune”. Questa è la loro definizione, ma diventa problematica quando poi indicano le somiglianze anatomiche e sostengono che queste siano la prova di un’ascendenza comune. Tali argomentazioni a favore dell’omologia sono palesemente circolari [dei bias o pregiudizi - N.d.T.] (e quindi prive di spiegazioni) perché sono tentativi di dimostrare ciò che era già stato dato per scontato!3
Al centro dell’argomentazione a favore dell’omologia c’è l’idea che la somiglianza morfologica confermi la parentela, ma i confronti molecolari contrastanti tra animali sono come un bastone tra le ruote. Ad esempio, secondo una ricerca pubblicata nel 2004, un albero genealogico morfologico dei mammiferi indica gli Xenarthra (creature come bradipi, formichieri e armadilli) come un ramo molto “precoce” dei mammiferi placentati. Tuttavia, un albero genealogico molecolare delle stesse creature posiziona gli Xenarthra come se si fossero evoluti “molto più tardi”, dopo un gruppo chiamato Afrotheria – che include elefanti, tenrec, talpe dorate, toporagni elefante, iraci, oritteropi e lamantini.4
Come se non bastasse, le ultime scoperte del team di ricerca di Bath portano le cose a un altro livello. Oltre ad analizzare gli alberi evolutivi di 48 gruppi di animali e piante (confrontando gli alberi genealogici morfologici con gli alberi molecolari), Matthew Wills e colleghi hanno anche incrociato i dati con la posizione geografica di ogni creatura.2 Nessuno lo aveva mai fatto prima. Con loro grande sorpresa, “gli animali raggruppati tramite alberi molecolari vivevano più vicini geograficamente rispetto agli animali raggruppati tramite alberi morfologici”,2 portando il Prof. Wills ad ammettere:
“… a quanto pare abbiamo sbagliato molti dei nostri alberi evolutivi. Per oltre cento anni abbiamo classificato gli organismi in base al loro aspetto e alla loro struttura anatomica, ma i dati molecolari spesso ci raccontano una storia piuttosto diversa.”1

Quanto questa scoperta sia impegnativa per l’evoluzione dovrebbe essere evidente se si fa riferimento alle immagini dei diversi membri dell’Afrotheria (figura 1), mentre si legge quanto segue:
“Ad esempio, i minuscoli toporagni elefante, oritteropi, elefanti, talpe dorate e lamantini nuotatori provengono tutti dallo stesso grande ramo dell’evoluzione dei mammiferi, nonostante il fatto che abbiano un aspetto completamente diverso l’uno dall’altro (e vivano in modi molto diversi).
“Gli alberi molecolari li hanno raggruppati tutti in un gruppo chiamato Afrotheria, così chiamato perché provengono tutti dal continente africano.”1
Pensateci. Le istruzioni codificate del DNA di una creatura vengono utilizzate per produrre tutte le proteine che compongono la sua anatomia. Presumibilmente, le mutazioni genetiche benefiche di questo DNA sono la materia prima con cui lavora la selezione naturale, guidando così l’evoluzione di nuovi tessuti, organi e strutture corporee. Se è davvero così, perché questo grande disaccordo tra i confronti DNA/proteine e i confronti morfologici (quelli basati sull’aspetto)?
Il professor Wills ha ribadito questo dilemma evolutivo più di recente, evidenziando ancora una volta i risultati controintuitivi dello studio del suo team:
“Gli alberi evolutivi basati sui dati del DNA avevano due terzi di probabilità in più di corrispondere alla posizione della specie rispetto alle mappe evolutive tradizionali. In altre parole, gli alberi precedenti mostravano che diverse specie erano correlate in base all’aspetto. La nostra ricerca ha dimostrato che avevano molte meno probabilità di vivere vicini tra loro rispetto alle specie collegate dai dati del DNA.”5
In altre parole, tale ricerca sconvolge gli alberi genealogici evolutivi su tutta la linea. Per molto tempo, scrive Wills, le somiglianze nel cervello e nello scheletro di pipistrelli e primati (tra cui include gli esseri umani) hanno portato gli evoluzionisti a credere che fossero parenti stretti. I dati molecolari li hanno sorpresi tutti: “Sorprendentemente, i pipistrelli risultano essere più strettamente imparentati con mucche, cavalli e persino rinoceronti di quanto lo siano con noi.”5
“Abbiamo bisogno di una nuova teoria dell’evoluzione?”
Alcuni scienziati evoluzionisti hanno dissentito dal darwinismo puro per decenni, dando origine a numerose teorie e modelli alternativi del cambiamento evolutivo (vedi Appendice). Tuttavia, la versione neodarwiniana dell’evoluzione è ancora di gran lunga la più popolare. È quella che i bambini imparano a scuola e che viene generalmente propagata dai media tradizionali. Gli studiosi dell’evoluzione che hanno familiarità con la traiettoria del pensiero evoluzionistico non possono evitare di concludere che c’è qualcosa che non va: la proliferazione di idee e modelli alternativi è un indizio importante.
L’intero edificio dell’evoluzione è stato costruito su presunte somiglianze nell’aspetto degli organismi, sia viventi che estinti. Come abbiamo già visto, l’idea centrale darwiniana secondo cui la somiglianza nell’aspetto stabilisce una relazione si sta dimostrando errata. Gli esperti di fossili devono affrontare la realtà: in un colpo solo, i dati della biologia molecolare stanno spazzando via quasi due secoli di teorie paleontologiche e narrazioni popolari. Gli organismi viventi condividono spesso più somiglianze genetiche con creature dall’aspetto molto diverso nella stessa posizione geografica che con creature più morfologicamente simili in una parte diversa del pianeta. Stando così le cose, che valore hanno gli studi che si concentrano sui minimi dettagli dei confronti anatomici tra creature estinte da tempo, la maggior parte dei quali basati su resti molto frammentari e talvolta su semplici frammenti ossei?
Tuttavia, sarebbe ingenuo pensare che questo conflitto tra teoria e fatti, per quanto straordinario sia, causerà una rivalutazione fondamentale del “fatto” dell’evoluzione stessa. La posta in gioco è decisamente troppo alta. Il dibattito sulle origini va ben oltre i dati fattuali di biologia, genetica e paleontologia. Per molti, l’evoluzione è fondamentale per una visione del mondo che ha fatto a meno del Dio Creatore. I “veri credenti” hanno investito troppo nel paradigma per metterne in discussione la realtà, non solo intellettualmente, ma anche emotivamente, persino spiritualmente.
È confortante, tuttavia, che sempre più scienziati stiano pensando fuori dagli schemi. Contrariamente all’accusa di essere tutti fondamentalisti religiosi nascosti, molti di questi individui non hanno alcun impegno religioso dichiarato. La loro preoccupazione è di andare dove conducono le prove. Desiderano essere liberi dai dogmi e pronti a sfidare coloro che vorrebbero limitare la libertà di pensiero e di parola nella scienza, che si tratti dei minacciosi sacerdoti del neodarwinismo o dei loro volenterosi accoliti nei media laici.
Da alcuni anni, un numero crescente di scienziati con dottorato provenienti da istituzioni accademiche di tutto il mondo ha sottoscritto la seguente dichiarazione sul sito web A Scientific Dissent From Darwinism:
“Siamo scettici riguardo alle affermazioni secondo cui la mutazione casuale e la selezione naturale possano spiegare la complessità della vita. Un attento esame delle prove a sostegno della teoria darwiniana dovrebbe essere incoraggiato.”
Al momento in cui scriviamo, questa lista supera i 1.200 scienziati con dottorato di ricerca, il 38% dei quali sono professori di dipartimento.6 Nonostante le loro credenziali impeccabili, i critici hanno cercato di liquidarli come ignoranti scientifici, colpevoli di aver confuso le acque sulle presunte prove chiare e abbondanti dell’evoluzione. Tuttavia, questi fiacchi tentativi di liquidare questo vasto gruppo di critici del neodarwinismo non hanno contribuito a consolidare le inadeguatezze di una teoria fallimentare.
Da tempo, infatti, i principali biologi che credono nell’evoluzione hanno espresso la loro frustrazione per la mancanza di dibattito sui problemi della teoria standard. Finalmente, a quanto pare, alcune di queste lamentele stanno arrivando. Nel giugno 2022, Il Guardian (Regno Unito) ha persino pubblicato un articolo dal titolo provocatorio: “Abbiamo bisogno di una nuova teoria dell’evoluzione?”. Lo scrittore Steve Buranyi non ha usato mezzi termini:
“[C’è un problema con] la storia fondamentale dell’evoluzione, così come raccontata in innumerevoli libri di testo e best-seller di divulgazione scientifica. Il problema, secondo un numero crescente di scienziati, è che è assurdamente rozza e fuorviante”.7
Per i creazionisti biblici, denunce come questa sono incoraggianti. Nonostante i conflitti molto concreti tra i fatti e la teoria evoluzionistica, per non parlare dei numerosi disaccordi privati tra gli stessi scienziati evoluzionisti, pochi sono stati disposti a rendere pubbliche queste cose. Non sorprende che la persona media abbia dato per scontato che tutto vada bene. Un’ammissione molto significativa è che una pletora di libri di divulgazione scientifica, così come libri di testo scolastici, sono colpevoli di una narrazione evoluzionistica “assurdamente rozza e fuorviante”. Gli stessi scienziati evoluzionisti lo affermano! Oltre 20 anni fa, James Williams, un formatore di insegnanti presso l’Università del Sussex (Regno Unito), si lamentava in modo simile che “gli esempi di evoluzione usati nei libri di testo sono imperfetti e necessitano di un aggiornamento radicale” e che “il nostro insegnamento dell’evoluzione è scadente”.8 La situazione ora è molto peggiore.
Buranyi non si è fermato qui, tuttavia. I drastici problemi con il neodarwinismo, la cosiddetta “sintesi moderna”, sono stati riconosciuti decenni fa; ovvero l’idea, a lungo sostenuta da personaggi come Richard Dawkins, che la selezione naturale metta ordine e selezioni tra mutazioni casuali. Una nuova generazione di evoluzionisti si è resa conto da tempo che non è questa la risposta, come spiega Buranyi:
“Secondo la sintesi moderna, anche se le mutazioni si rivelassero comuni, la selezione naturale, nel tempo, sarebbe comunque la causa principale del cambiamento, preservando le mutazioni utili ed eliminando quelle inutili. Ma non è questo che stava accadendo. I geni stavano cambiando – cioè evolvendosi – ma la selezione naturale non stava giocando un ruolo. Alcuni cambiamenti genetici venivano preservati senza alcuna ragione se non per puro caso. La selezione naturale sembrava dormire al volante.”7
È vero che i geni possono cambiare, ma nessuno di questi casi incoraggia minimamente l’evoluzione neodarwiniana. Al contrario, le mutazioni invariabilmente interrompono e distruggono le cose. Le mutazioni possono portare a nuovi alleli, nuove versioni di geni esistenti, che portano a nuovi tratti (sebbene molti tratti non siano il risultato di mutazioni). Tuttavia, non si è mai osservato che le mutazioni generino il tipo di nuova complessità auspicata dai neodarwinisti. Inoltre, la fiducia degli evoluzionisti nel potere della selezione naturale di contribuire alla generazione di nuove caratteristiche funzionali è stata mal riposta.
La valutazione di Buranyi è appropriata, ma rivela ancora una volta quanto pochi esperti abbiano la volontà di confessare il fallimento totale del neodarwinismo:
“Forse il cambiamento più grande rispetto ai giorni di gloria della teoria a metà del XX secolo è che le sue affermazioni più ambiziose – secondo cui semplicemente comprendendo i geni e la selezione naturale, possiamo comprendere tutta la vita sulla Terra – sono state abbandonate, o ora sono accompagnate da avvertenze ed eccezioni. Questo cambiamento è avvenuto con poca pubblicità. … non è stata fatta alcuna formale valutazione dei suoi fallimenti o scismi [enfasi aggiunta].”7
“Il neodarwinismo deve mutare per sopravvivere”
Due mesi dopo l’articolo del Guardian, i coautori e professori statunitensi Olen R. Brown e David A. Hullender si sono uniti alla mischia con un articolo intitolato “Il neodarwinismo deve mutare per sopravvivere”.9 Sono fermamente convinti che i cambiamenti su piccola scala osservati nel mondo naturale, spesso definiti “microevoluzione”, non siano di alcun aiuto nello spiegare immaginari cambiamenti su larga scala ipotizzati da Charles Darwin e dai suoi successori. Considerando le cose da una prospettiva diversa, Brown e Hullender sottolineano il fatto che l’improbabilità statistica del neodarwinismo è nell’ordine di 10-50, collocando la capacità della teoria di spiegare una complessità autenticamente nuova (macro cambiamenti) nel regno dell’impossibile:
“Pertanto, la sopravvivenza del più adatto è illogica quando proposta come adeguata per selezionare l’origine di tutti i tipi corporei e funzioni metaboliche nuove, complesse e importanti, perché i molteplici cambiamenti nei molteplici genomi richiesti presentano fasi intermedie senza vantaggi; ragionevolmente la selezione non si verificherebbe, e logicamente lo svantaggio o la morte prevarrebbero”.9
Questo è un ulteriore ostacolo alla tanto amata teoria, e rappresenta un serio ostacolo per i sostenitori del naturalismo. Qual è, allora, l’alternativa, se mutazione e selezione non possono produrre un cambiamento evolutivo significativo? Potrebbe esserci uno scopo nella biologia, un “Disegno Intelligente”? Naturalmente, questo è da tempo un grande tabù per la maggior parte degli scienziati. Di conseguenza, è confortante vedere Brown e Hullender affermare che “La logica esige che [l’evoluzione] sia aperta all’indagine. Ciò richiede innanzitutto un’apertura alle idee e la scienza deve essere aperta a nuove idee”.9
Inoltre, pur non utilizzando la famosa frase di Michael Behe, Brown e Hullender riconoscono la seria sfida che la “complessità irriducibile” pone al cambiamento evolutivo su larga scala:
“Darwin scrisse in L’origine delle specie…: ‘Se si potesse dimostrare che esiste un organo complesso, che non possa essersi formato da numerose, successive e lievi modificazioni, la mia teoria crollerebbe completamente. Ma non riesco a trovare alcun caso del genere”. Oggi, i casi mancanti di Darwin sono abbondanti, inclusa ogni transizione complessa verso un nuovo tipo di corpo, ciclo metabolico o catena metabolica. Processi multifase sono normalmente richiesti a ogni fase evolutiva”.9
“Darwin ha sbagliato”
Si potrebbe essere perdonati se si pensasse, a giudicare da questa recente ondata di ammissioni di alto profilo, che non tutto vada bene con la teoria dell’evoluzione, che questo tipo di ammissioni siano nuove. In effetti, se ne mormora da tempo. Ad esempio, nel loro libro What Darwin Got Wrong (2011), Jerry Fodor e Massimo Piattelli-Palmarini affermano candidamente che il darwinismo è “fatalmente imperfetto”, e scrivono:
“OK; quindi se Darwin ha sbagliato, qual è secondo voi il meccanismo dell’evoluzione?” Risposta breve: non sappiamo quale sia il meccanismo dell’evoluzione. Per quanto ne sappiamo, nessuno sa esattamente come si evolvono i fenotipi.”10
“In effetti, non sappiamo molto bene come funziona l’evoluzione. Né lo sapeva Darwin e (per quanto ne sappiamo) nessun altro.”11
Le opinioni di scrittori del loro calibro non sono facilmente respinte. Ora in pensione, Fodor è un rispettato filosofo americano la cui carriera include lunghi periodi al Massachusetts Institute of Technology, alla City University di New York e alla Rutger University. Piattelli-Palmarini ha svolto la sua carriera in biofisica e biologia molecolare, ed è attualmente professore di Linguistica e Scienze Cognitive presso l’Università dell’Arizona. Non si può certo accusarli di avere una qualche forma di pregiudizio teleologico. Piuttosto, affermano: “vogliamo, con tutto il cuore, essere umanisti laici. Infatti, entrambi affermiamo di essere atei convinti, tesserati, iscritti, convinti e senza esclusione di colpi. Cerchiamo quindi spiegazioni completamente naturalistiche dei fatti dell’evoluzione”.12
Nell’edizione del 2011 di What Darwin Got Wrong (pubblicata per la prima volta nel 2010), Fodor e Piattelli-Palmarini hanno incluso un capitolo aggiuntivo, “Postfazione e risposta alle critiche”, rivelando che “il libro è stato accolto molto male [dai loro colleghi evoluzionisti]. Quasi tutte (anche se non del tutto) le recensioni sono state ostili e alcune addirittura isteriche”.13 Tuttavia, negli anni successivi, un numero sempre maggiore di scienziati si è dimostrato disposto a uscire allo scoperto.
Nel 2013, Carrie Arnold, scrittrice scientifica per New Scientist, ha mostrato un’insolita sincerità sottolineando qualcosa che i biologi creazionisti sottolineavano da tempo:
“Mentre la selezione naturale spiega come le specie cambiano nel tempo, spiegare come nascono le nuove specie si è rivelato piuttosto complicato. L’Origine delle specie di Darwin in realtà non dice nulla sull’origine delle specie”.14
Se un sostenitore della creazione biblica o del disegno intelligente avesse sostenuto la stessa tesi, si possono facilmente immaginare le accuse e le grida di “irregolarità”. Lo stesso anno, Stephen Meyer affermò quanto segue nel suo libro tour de force, Darwin’s Doubt:
“La letteratura tecnica in biologia è ormai piena di biologi di fama mondiale che esprimono regolarmente dubbi su vari aspetti della teoria neodarwiniana, e in particolare sul suo principio fondamentale, ovvero il presunto potere creativo della selezione naturale e del meccanismo di mutazione [enfasi aggiunta]”.15
È credibile che gli scienziati non siano stati in grado di dare concretezza all’affermazione principale del titolo del famoso libro di Darwin del 1859, L’origine delle specie? Dopo altri 160 anni di ricerca da parte di un vasto numero di scienziati? Nel 2015, lo scrittore di scienze biologiche Bob Holmes ammise:
“La speciazione rimane ancora uno dei più grandi misteri della biologia evolutiva e la visione inesplorata della selezione naturale che porta a innovazioni su larga scala non è vera”.16
“Non è vera”, notate. Darwin si sbagliava davvero! Nello stesso anno, Suzan Mazur intervistò diversi biologi di fama mondiale e pubblicò questi scambi nel suo libro, The Paradigm Shifters: Overthrowing the hegemony of the culture of Darwin [I mutatori di paradigma: rovesciare l’egemonia della cultura di Darwin – N.d.T.]. Considereremo solo due di questi dissenzienti dal neodarwinismo.
In primo luogo, James A. Shapiro (Università di Chicago) ha affermato:
“Il cambiamento del genoma non è il risultato di incidenti. … È nel corso della riparazione di danni o della risposta ad altri input … che le cellule attivano i sistemi di cui dispongono per ristrutturare i propri genomi. Quindi, ciò che abbiamo è qualcosa di diverso dagli incidenti e dagli errori come fonte di cambiamento genetico. Abbiamo quella che chiamo “ingegneria genetica naturale” [enfasi aggiunta]”.17
In altre parole, questo professore di biochimica e biologia molecolare è fermamente convinto che il cambiamento mutazionale casuale non sia di alcun aiuto all’evoluzione. Shapiro è un altro scienziato che non si lascia facilmente liquidare. Oltre a brillanti risultati accademici, ha ricevuto l’onorificenza di Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico.18
In secondo luogo, la defunta Mae-Wan Ho (co-fondatrice e direttrice dell’Institute of Science and Society, Regno Unito) era una genetista affermata. Fu schietta riguardo allo status quo, così come lo vedeva:
“Penso che la Sintesi Moderna debba essere completamente sostituita e, sfortunatamente, coloro che sono molto legati al neodarwinismo non vogliono considerare le prove. Molti di loro non conoscono affatto la genetica molecolare. O, come [Richard] Dawkins, diranno: ‘Non ci credo proprio. Non sono scienziati“.19
Queste sono solo alcune delle tante voci di scienziati, la maggior parte dei quali evoluzionisti, che hanno chiesto una valutazione onesta dello stato della teoria dell’evoluzione. Credono fermamente che ci sia un disperato bisogno di una nuova teoria dell’evoluzione.
Le illusioni non sono una risposta.
Molti altri, tuttavia, preferiscono nascondere la testa sotto la sabbia, aggrappandosi all’idea irrazionale che il cambiamento evolutivo debba sicuramente essersi verificato, nonostante queste sfide scientifiche apparentemente insormontabili. Forse stiamo sottovalutando la capacità dell’evoluzione?
“Forse l’innovazione evolutiva è più facile di quanto pensiamo? Forse l’evoluzione non deve aspettare le innovazioni? Forse il suo motore creativo è più potente di quanto gli attribuiamo? La sorprendente velocità con cui l’evoluzione può rispondere alle nuove opportunità suggerisce questa possibilità.
”… E se molte innovazioni nascessero prima del previsto, ma prosperassero solo quando le condizioni fossero favorevoli? [enfasi aggiunta].”20
A cui rispondiamo che non c’è nulla di male nell’usare la propria immaginazione, ma “forse” e “e se…” non sono sostituti accettabili di scoperte scientifiche collaudate.
La vera risposta alla domanda posta da questo articolo è “no, non è necessaria una nuova teoria dell’evoluzione”. Invece, gli evoluzionisti dovrebbero fare un passo indietro e chiedersi: “se l’evoluzione neodarwiniana è stata falsificata (e Darwin e i suoi seguaci sbagliano), perché sono così spinto a trovare una spiegazione naturalistica alternativa per le origini?”. Cosa c’è di sbagliato nel riconoscere che gli esseri viventi mostrano prove evidenti di un disegno intelligente e che in effetti sono stati progettati per adattarsi? Perché non seguire le prove fin dove conducono?
Appendice: L’evoluzione della teoria evoluzionistica
Quello che segue è un elenco cronologico delle diverse teorie evoluzionistiche di cui l’autore è venuto a conoscenza e che ha studiato dalla fine degli anni ‘80. Non è esaustivo; ulteriori teorie sono fornite alla fine di questi dieci punti:
- Darwinismo (1859, Charles Darwin). La visione standard della selezione naturale, prima dell’avvento della genetica e della conoscenza delle mutazioni genetiche.
- Darwinismo sociale (termine usato per la prima volta nel 1877, ma più popolare nel secondo dopoguerra). Ha legami con il primo movimento eugenetico ed è il tentativo di applicare l’evoluzione alla sociologia e alla politica umana.
- Neodarwinismo (fine anni ‘30, in seguito soprannominato “evoluzione lenta e continua” da Gould, in risposta a coloro che criticavano il modello degli equilibri punteggiati elaborato da lui e Niles Eldredge, vedi sotto). È il risultato della sintesi del darwinismo classico con la genetica (l’idea delle mutazioni come fonte di novità). Numerosi sono stati i suoi sostenitori di spicco: Theodosius Dobzhansky, Ronald Fisher, John B.S. Haldane, Ernst Mayr, George Gaylord Simpson e altri. Richard Dawkins e Jerry Coyne sono solo due dei suoi sostenitori odierni. La speciazione simpatrica e allopatrica sono idee chiave all’interno di questo modello.
- Ipotesi del Mostro Speranzoso (1940, Richard Goldschmidt, definizione da lui stesso coniata per la sua idea!). Una sorta di teoria evolutiva saltazionale che prevede grandi mutazioni per colmare il divario percepito tra micro- e macroevoluzione.
- Equilibri Punteggiati (anni ‘70, soprannominata “evoluzione a scatti” dai suoi critici), che include la speciazione allopatrica come idea centrale. Principali sostenitori: Stephen Jay Gould e Niles Eldredge.
- Simbiogenesi (un vecchio termine, del 1926). Fu trasformata in una vera e propria teoria evolutiva da Lynn Margulis (1938-2011) mentre era una ricercatrice post-dottorato, ma soprattutto in seguito ai suoi libri del 1998 e del 2002. Divenne famosa all’inizio degli anni ‘70 dopo aver pubblicato la sua teoria dell’endosimbiosi per spiegare l’origine dei mitocondri e dei cloroplasti dalla fusione di vari organismi procarioti.
- Teoria Neutrale (anni ‘60). Il principale sostenitore fu Motoo Kimura (giapponese; menzionato nel libro di John Sanford, “Genetic Entropy & the Mystery of the Genome”); si veda anche l’influente libro di Kimura del 1983, “The Neutral Theory of Molecular Evolution” (C.U. Press).
- Evo-Devo (o sviluppo evolutivo). Non è facile stabilire una data, poiché include molte idee e scoperte che risalgono a un secolo fa. Dagli anni ‘80, la scoperta e la successiva spiegazione della funzione dei geni Hox (omeotici, omeobox) è stata una parte fondamentale dell’Evo-Devo. Nel pensiero di molti biologi, è ora un fattore che contribuisce in modo significativo al cambiamento evolutivo su larga scala. Tra i suoi sostenitori più noti ci sono Sean B. Carroll e Jack Horner.
- Ingegneria Genetica Naturale (libro del 2011, “Evolution: A view from the 21st Century”, James Shapiro); una seconda edizione è apparsa nel 2022. Per citare uno dei titoli dei capitoli del libro, si tratta di un “approccio sistemico alla generazione di novità funzionale”. James Shapiro nega esplicitamente che la mutazione casuale e la selezione naturale siano capaci di cambiamenti evolutivi su larga scala; ad esempio: “Il ruolo della selezione è quello di eliminare le novità evolutive che si dimostrano non funzionali e interferiscono con le esigenze di adattamento. La selezione opera come una forza purificatrice, ma non creativa [enfasi aggiunta]”.21
- “Complexity by Subtraction” (un articolo del 2013 su Evolutionary Biology22) è un tentativo di aggirare le sfide della complessità irriducibile (Michael Behe). Sostenitori: Daniel McShea e Wim Hordijk.
Inoltre, Andrew Lamb ha utilmente elencato online quanto segue:
“Altre teorie dell’evoluzione (per lo più scartate) includono la Massima Produzione di Entropia (MEP), la Dinamica di Popolazione, la Variazione Facilitata, la Semi-Meiosi, la Costruzione di Nicchia, la Panspermia, la Teoria del Tasso Metabolico, la Zoogenesi, il Lamarckismo, l’Ortogenesi, la Pangenesi, la Teoria di Gaia, l’Evo-Devo, la Simbiogenesi. Ce ne sono molte altre.”23
Riferimenti e note
- Università di Bath, Uno studio suggerisce che la maggior parte dei nostri alberi evolutivi potrebbe essere errata, phys.org, 1 giugno 2022. Torna al testo.
- Oyston, J.W., Wilkinson, M., Ruta, M., e Wills, M.A., Le filogenesi molecolari si adattano meglio alla biogeografia rispetto a quelle morfologiche, Communications Biology 5:521, 31 maggio 2022. Torna al testo.
- Un’utile discussione su questo argomento si trova nel capitolo 4 di: Wells, J., Icons of Evolution: Science or myth? Regnery Publishing, Washington DC, pp. 59–66, 2002. Torna al testo.
- Springer, M.S. et al., Molecules consolidate the placental mammal tree, Trends in Ecology and Evolution 19:430–438, 2004. Torna al testo.
- Wills, M., Evolutionary tree of life: modern science is showing how we got so much wrong, theconversation.com, 23 giugno 2023. Torna al testo.
- Dissenso da Darwin: esiste un dissenso scientifico dal darwinismo e merita di essere ascoltato, dissentfromdarwin.org; consultato il 21 agosto 2023. Torna al testo.
- Buranyi, S., Abbiamo bisogno di una nuova teoria dell’evoluzione? theguardian.com, 28 giugno 2022. Torna al testo.
- Bell, P., Don’t believe evolution—just accept it! creation.com, 19 maggio 2003. Torna al testo.
- Brown, O.R. e Hullender, D.A., Il neodarwinismo deve mutare per sopravvivere, Progress in Biophysics and Molecular Biology 172:24–38, agosto 2022 | doi:10.1016/j.pbiomolbio.2022.04.005. Torna al testo.
- Fodor, J. e Piattelli-Palmarini, M., What Darwin Got Wrong, Profile Books, Londra, p. 153, 2011. Torna al testo.
- Fodor e Piattelli-Palmarini, rif. 10, p. xvi. Torna al testo.
- Fodor e Piattelli-Palmarini, rif. 10, rif. 10, p. xv. Torna al testo.
- Fodor e Piattelli-Palmarini, rif. 10, p. 167. Torna al testo.
- Arnold, C., L’altro te: i microbi che vivono dentro di noi non svolgono solo un ruolo vitale per la nostra salute, ma plasmano anche la nostra evoluzione, New Scientist 217(2899):30–34, 12 gennaio 2013. Torna al testo.
- Meyer, S.C., Il dubbio di Darwin: l’origine esplosiva della vita animale e il caso del Disegno Intelligente, HarperCollins, p. x, 2013. Torna al testo.
- Holmes, B., L’incidente delle specie; in: Michael Brooks (a cura di), Il caso: la scienza e i segreti della fortuna, della casualità e della probabilità, Profile/New Scientist, Londra, pp. 34–35, 2015. Torna al testo.
- Citato in: Mazur, S., The Paradigm Shifters: Overthrowing ‘the hegemony of the culture of Darwin’, Caswell Books, New York, p. 15, 2015. Torna al testo.
- La regina Elisabetta II gli ha conferito l’Ordine dell’Impero Britannico (OBE) nel 2002 per il suo ruolo significativo nel promuovere giovani americani illustri alle borse di studio Marshall nelle università britanniche. Torna al testo.
- Mazur, rif. 17, p. 44. Torna al testo.
- Wagner, A., Sleeping beauties: the evolutionary innovations that wait millions of years to come good, theguardian.com, 18 aprile 2023. Torna al testo.
- Una recensione tecnica del libro è disponibile su: Wilkins, A.S., Genome Biol Evol 4(4):423–426, 24 gennaio 2012. Torna al testo.
- McShea, D.W. e Hordijk, W., Complessità per sottrazione, Evolutionary Biology 40:504–520, 13 aprile 2013. Torna al testo.
- Lamb, A., Braterman ‘slam dunk’ flunk (Braterman ‘slam dunk’ fallito), creation.com, 28 novembre 2017. Torna al testo.

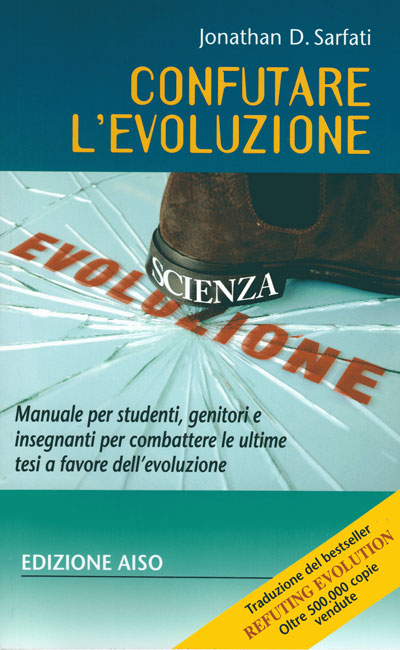
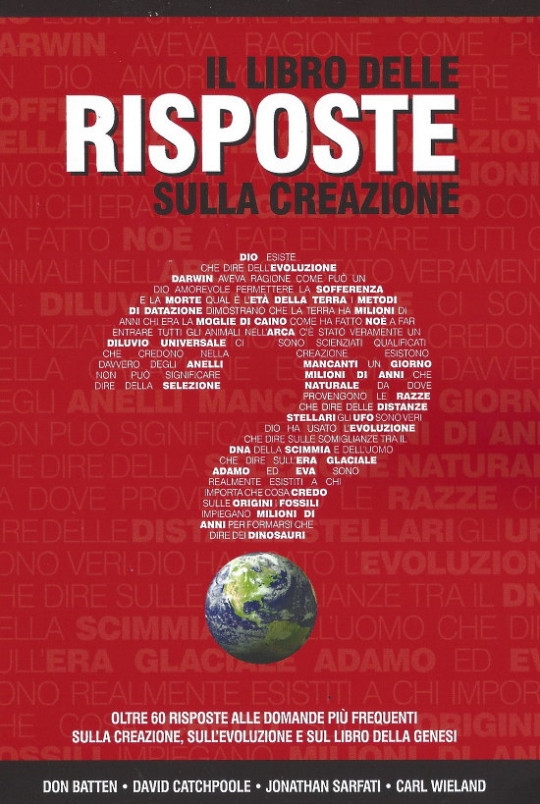
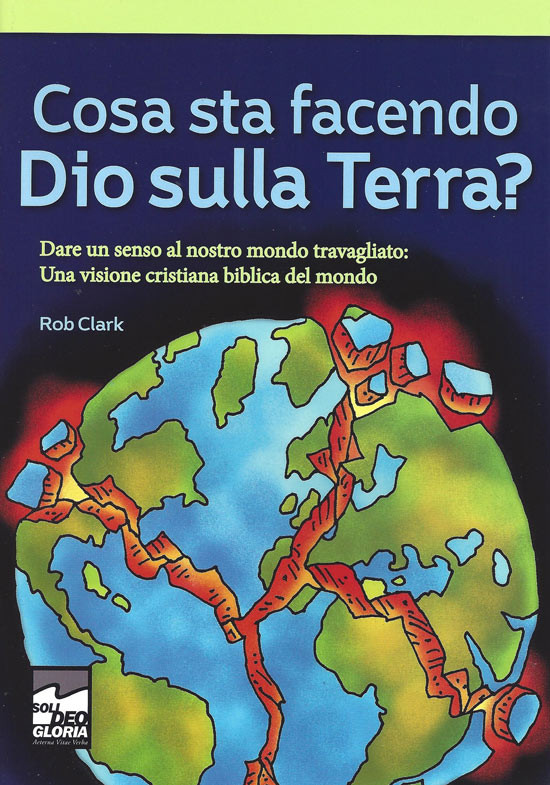
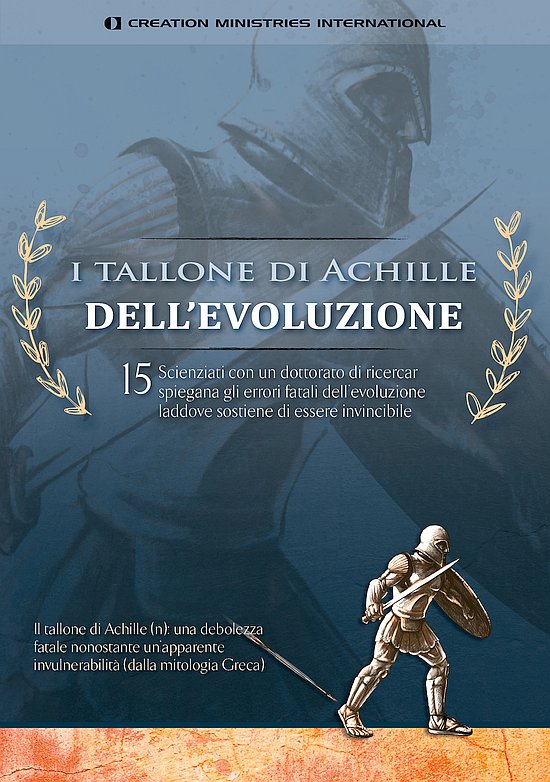
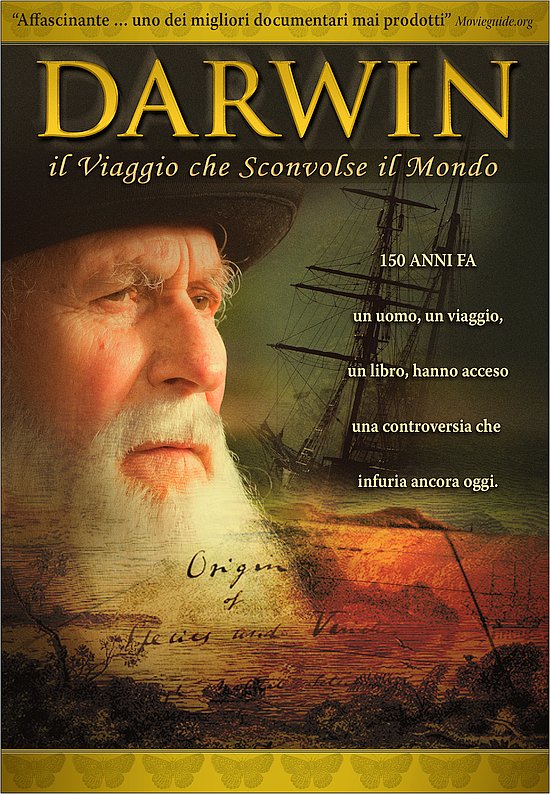
Readers’ comments
Comments are automatically closed 14 days after publication.